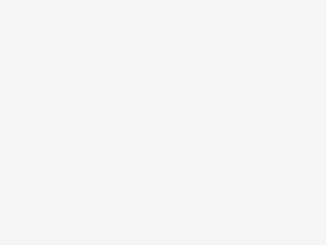Dopo lunghe e penose ricerche, solo per voi, fedeli lettori, Puntarella Rossa ha trovato quello che al momento sembra essere il peggior ristorante di Roma. Stiamo parlando di “Peppino a Mare”, sul lungomare di Ostia. Ovviamente, la palma marrone di “peggior ristorante di Roma” non si dà così, a caso. Proprio come per l’ottimo, a caratterizzare il pessimo concorrono una serie di elementi rari, spesso introvabili. Che vanno saputi cogliere e apprezzare. Non basta mangiare male, non basta la scortesia del servizio, non basta la bruttezza del posto e la follia del conto. Ci vuole che tutti questi elementi si combinino insieme nel più sgradevole dei modi. Una sorta di magia al contrario. Esattamente quello che succede, di questi tempi, da Peppino a Mare.
Dopo lunghe e penose ricerche, solo per voi, fedeli lettori, Puntarella Rossa ha trovato quello che al momento sembra essere il peggior ristorante di Roma. Stiamo parlando di “Peppino a Mare”, sul lungomare di Ostia. Ovviamente, la palma marrone di “peggior ristorante di Roma” non si dà così, a caso. Proprio come per l’ottimo, a caratterizzare il pessimo concorrono una serie di elementi rari, spesso introvabili. Che vanno saputi cogliere e apprezzare. Non basta mangiare male, non basta la scortesia del servizio, non basta la bruttezza del posto e la follia del conto. Ci vuole che tutti questi elementi si combinino insieme nel più sgradevole dei modi. Una sorta di magia al contrario. Esattamente quello che succede, di questi tempi, da Peppino a Mare.
La prova Il solo ingresso al ristorante mette in allerta i sensi del cronista gastronomico. Prima ancora di raggiungere il suo tavolo – annegato nella sala giallastra e affacciato su un tendaggio pesante, rosso pompeiano – il nostro viene infatti intercettato da un giovane cameriere guizzante e lesto, il quale, senza nemmeno alludere all’idea di un menu o di una carta o di un qualcosa di scritto, chiede prontamente: “Antipastino e primo?”. Nutrito di una certa professionale diffidenza (che come si sa non è mai troppa) il nostro cronista pretende di vedere un menu. Richiesta che viene accolta con il contegno tipico di chi raccoglie una sfida insolente, come a dire “mo ti faccio vedere io”. Dopo qualche istante viene recapitato infatti al tavolo un opuscolo striminzito, quattro fogli redatti in maniera a dir poco sbrigativa. Una sorta di codice. Elencate, non ci sono pietanze e piatti. Ma solo le indicazioni vaghe dei semilavorati, se non addirittura delle materie prime. “Pesce”, “moscardini”, “gamberi”, “cozze”. Non una sola parola sulla loro preparazione. Non un accenno alla loro natura. Niente. Interrogato, il cameriere fornisce spiegazioni minimaliste, persino infastidite. “I moscardini? in umido”. “Le cozze? Sauté. I gamberi? So’ gamberi (sic)”. Quanto al prezzo, poi, questo viene indicato al peso, come usa spesso.
L’ordinazione procede dunque a tentoni: “Due antipasti di mare, un’orata alla griglia, un piatto di gamberi (so’ gamberi)”; da bere, in assenza della lista di vini, il cronista prova a limitare i danni e si consegna a una bottiglietta (375 ml) di Rapitalà e una di acqua frizzante (Ferrarelle). Gli antipasti vengono catapultati sul tavolo qualcosa come 35 secondi dopo l’arrivo dell’ordine in cucina, tipico segno di una preparazione accurata, piena d’amore e attenzione.
Il piattone bianco è tripartito: un terzo è dedicato a una dose di insalata mista precotta e annegata nell’olio (e sulla quale sembrava caduta l’intera saliera), un terzo a quattro alici marinate d’essai, e un terzo a un pezzo di salmone (3-4 cm x 2 cm) per altro assediato dalle cipolle. Il tutto, buttato lì sul piatto come da una pala meccanica, come calce su un reattore atomico in frantumi. I vari sapori, tutti fortissimi, sono di conseguenza mischiati e distrutti.
Ecco che dalla cucina piomba sul tavolo, come una maledizione o una grandinata, il secondo. Tenendo il piatto in sospensione (circa un metro e sessanta da terra), il cameriere si avvicina il meno possibile al tavolo e volteggiando domanda tra il frettoloso e l’assertivo: “Ci penso io?”. Qualche istante per capire a cosa dovrebbe “pensarci lui” e il piatto in sospensione è già fuori dal campo visivo di chiunque, dall’altra parte della sala, pronto per l’operazione di diliscamento della (fin qui solo supposta) orata. Dopo pochissimo,il cameriere torna, abbandona il piatto con i gamberi (so’ gamberi) di fronte alla commensale e quello con la supposta orata davanti al nostro. O meglio, con quel che resta della supposta orata. Due filetti e mezzo, formato mignon, belli attaccati alla pelle bruciata della fu bestia. Il pasto, viste le proporzioni del tutto, si consuma nel giro di pochi mesti minuti e viene chiuso, così, tanto per sbrigarsi a dimenticare, da un sorbetto al limone e una fetta d’ananas “dal sapore e dalla consistenza di un cetriolo”, per dirla con le parole della commensale.
Il cetriolo Il vero cetriolo, però arriva subito dopo. Il conto. Centoundici euro. Nemmeno la decenza di fare cifra tonda. Il nostro chiede se c’è un errore, magari alla cassa hanno conteggiato il vino da un litro e non la bottiglietta. No, nessun errore, dice il cameriere che anzi, senza un filo di ironia, rimprovera: «Io vi ho dato la lista, avevate modo di vedere i prezzi!». L’obiezione – i prezzi erano espressi a peso, i pesci non ce li avete fatti nemmeno vedere e noi la bilancia non l’abbiamo portata – non viene raccolta. «Questa somiglia a una rapina, ne siete consapevoli?». La successiva osservazione (successiva al pagamento), avanzata alla cassiera, finisce infranta contro il muro di insofferenza tipico di chi ormai ha ottenuto quello che si era prefissato (i suddetti 111 euro): «Ve siete magnati quattro etti di orata» dice la donnina secca.
Il cronista, morso dal dubbio, si tasta l’addome in cerca di tracce di questi quattro etti di orata, ma non trova niente. Scuote la testa, si gira, infila le mani in tasca ed esce dal locale accendendosi una sigaretta. La notte, sul litorale, è profonda e fresca. Le spiagge riposano e, poco distante, il lungomare tutto illuminato, battuto dal vento e deserto, sembra una pista d’atterraggio. La sua confidenza con gli elementi rasserena. La porta del ristorante si apre di nuovo, ne escono due ragazzetti. Lui ha la faccia simpatica, lei è carina e ha il corpo compatto come quello di una foca. Lui guarda il cielo e sussurra sorridendo: «Mortacci loro». Lei sorride, gli dà una spinta e poi gli salta al collo, baciandolo.
Lungomare Amerigo Vespucci 102, 56320247. Sito