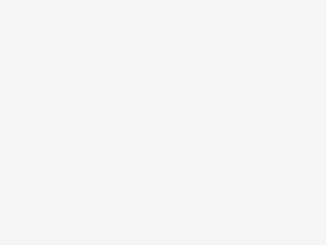Maccheroni, piazza delle Coppelle 44, tel 06-68307895
Possiamo chiamarle, se volete, forme residuali di epica metropolitana: andare, una sera afosa di luglio, a mangiare insieme ad amici esigenti ma, purtroppo, forestieri e quindi affascinati dalle Gtr (grandi trappole della romanità) in un ristorante risaputamente turistico. Affrontare il caldo, la folla, il sudore, la camicia che si appiccica all’addome, ma soprattutto affrontare l’ironia del tuo amico del cuore, esperto di cucina e di ristoranti, che quando glielo dici, «Stasera vado a mangiare da Maccheroni alle Coppelle», anche se glielo dici sottovoce e con tutto il necessario pudore del caso, ti ride inesorabilmente in faccia e ti tratta come un qualunque turista milanese che abbia letto per caso quel famoso trafiletto sul Messaggero, «Lady Obama impazzita per Maccheroni».
– «Lo so che è turistico, ma io mi ricordo di una volta tanti anni fa che in effetti i primi si potevano mangiare»
– «Ecco, hai detto bene, tanti anni fa».
– «Vabbè ma viene a Roma quel mio amico che ci teneva».
– «Vedi tu, magari è decente, io non ci andrei mai».
E invece ci vado. Maccheroni, dunque, «caratteristico Ristorante ubicato in Piazza delle Coppelle» (se solo avessi letto il sito prima… se avessi saputo che era ubicato mai ci sarei andato…).
L’ingresso in sala ricorda quello del commissario Logatto in Fracchia la belva umana, vi ricordate «non sono ricchione non sono fri frì»?
Ecco, così. Un po’ di casino con la prenotazione poi, siccome i tavolini di fuori e pure quelli di dentro sono onusti d’anglosassoni alticci per colpa del rosso canaglia della casa, io e i miei amici esigenti veniamo scaraventati nella “cripta”, una specie di catacomba inagibile apparecchiata a mo’ cantina.
I camerieri, va detto, sono simpatici, e questo alla fine della serata rimarrà l’unico punto a favore di uno dei posti peggiori (tra quelli più reclamizzati) della capitale. Mi metto a sedere e mi viene portato un bel canestrello di prodotti da forno, la tipica pizza romana, però nella sua versione peggiore: vecchia di quattro giorni e talmente umida da sembrare a tratti lingua bollita, e poi la solita dose di pane raffermo. (Sul pane raffermo dei ristoranti sarà il caso, un giorno, di scrivere un saggio).
Do un morso, rimango composto, poso la fetta, mastico, deglutisco, distolgo l’attenzione e avvio la conversazione. Poi avvicino il cameriere e gli chiedo la lista dei vini. Lui mi scruta un pochino poi con aria complice mi sorprende: «Permette un suggerimento?».
«Prego».
«Un prodotto laziale tipico»
«Oibò»
«Uno Shiraz, Casale del Giglio».
Hai capito che trovata! Un vino originale, un prodotto laziale tipico. Però capisco l’antifona e cedo subito: «Ottimo». E in effetti la scelta si rivelerà vincente: l’unico prodotto di qualità media di una serata dominata dal peggio.
Arriva il momento dell’ordinazione. Guardo il menù e penso: vabbè butto giù due appunti che faccio una recensione per Puntarellarossa (sono pur sempre puntarella secondaria, io). Il menu è di una tristezza antica. Una manciata di piatti romani buttati lì alla rinfusa come mutande sporche nel cesto della lavatrice, senza un briciolo di cura o di amore. Quindi, senza un briciolo di cura e di amore, ordiniamo anche noi: «cacio e pepe», dicono immancabilmente i miei ospiti, «trippa», dico io.
Ecco, la trippa. È sempre un buon test, la trippa. Perché è difficile da cucinare e difficilissima da presentare. Da come ti portano la trippa si capisce tutto. Ci sono quelli che fanno le acrobazie con la mentuccia, quelli che inventano canestri di pecorino, quelli che puntano sul rustico. E quelli che te la buttano a casaccio sul tavolo. Dietro ogni trippa, una storia, una passione, una versione del nulla. Passa una buona mezz’ora, forse anche quaranticinque minuti, un tempo infinito nel quale la mia fantasia vaga per esecuzioni bovine e macelli spietati. Mi immagino i camerieri simpatici che ammazzano ed eviscerano povere bestie indifese, mattatoi insaguinati, dolori e muggiti d’ogni tipo, vitelli orfani.
E quando il piatto arriva, buttato ovviamente a casaccio sul tavolo, capisco le reali proporzioni della mia ingenuità. Avrei fatto meglio a immaginare fabbriche tedesche e laboratori e forni a microonde. Più che una cena è un’autopsia. La bestia sarà stata ammazzata qualche lustro prima del servizio e cucinata subito dopo. Il retrogusto di chellophane e la temperatura delle listarelle, una ventina di gradi, tradiscono un certo effetto “quattro salti in padella”. Ma la cosa peggiore, più offensiva, è la ricetta. Parmigiano invece del pecorino, manco l’ombra di una fogliolina di menta e un sugo di pomodoro che ammazzerebbe ogni altro sapore.
Mentre mi interrogo su quanto potrà mai costare al Mercato Trionfale una piantina di menta, decido di provare il cacio e pepe dei miei ospiti le cui facce non proprio entusiaste mi erano sin lì sfuggite. Avete presente il pongo? Certamente sì, aggiungeteci un po’ di brodo di cottura e di pepe e avrete una riproduzione fedele del piatto.
Proprio mentre cerco di giustificarmi con i miei ospiti (ma la colpa in realtà è proprio loro che hanno letto quel maledetto trafiletto sulla povera lady Obama che chissà cosa penserà di noi romani e della nostra cucina a questo punto), arriva il cameriere che mi chiede come procede la serata. Gli faccio presente che la forchetta si regge in piedi nel piatto della cacio e pepe, lui si scusa un po’ imbarazzato e allora io per pietà concedo, mentendo: “Però la trippa era eccezionale”.
Mi alzo, pago il conto, 82 onesti euro, e insieme ai due ospiti esigenti sparisco nella rovente notte romana, pensando a quando la mattina dopo il mio amico commenterà caustico: «La corpa nun è mica loro, la corpa è tua che ce vai».